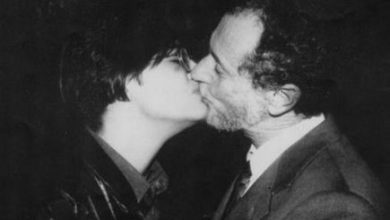In una scena del film Totò, Peppino e i fuorilegge, il grande Antonio De Curtis simulava un dente del giudizio dolente per nascondere di aver mangiato un’oliva sottratta alla moglie. A quasi 70 anni di distanza, la gag potrebbe non suscitare più la stessa ilarità nel pubblico, considerato che si sta riducendo il numero di persone che hanno realmente provato quel genere di sofferenza. Oggi, infatti, i denti del giudizio tendono a svilupparsi sempre meno nelle nuove generazioni.
Non ci sono ancora dati definitivi che documentino questa tendenza in maniera incontrovertibile, ma iniziano a emergere indizi importanti da diversi studi scientifici. Uno dei più interessanti arriva dall’India, dove si sta registrando un rapido aumento di coloro che non hanno sviluppato uno o più denti del giudizio: la loro percentuale tra i giovani nati nel nuovo millennio è salita fino al 35%. I numeri vanno ovviamente presi con le pinze, perché variano molto da Paese a Paese (si va dal 6% di Israele al 20% della Germania fino al 38% del Bangladesh), ma sono indicativi di un trend in atto.
In questo articolo
Denti del giudizio sempre più rari nelle nuove generazioni: come mai?
Secondo una ricerca dell’Università di Harvard, che ha passato in rassegna quasi un centinaio di studi di tutto il mondo, il mancato sviluppo di almeno un dente del giudizio interessa mediamente il 22% della popolazione globale, più donne che uomini, con ampie differenze a seconda della regione geografica di provenienza. I motivi sono probabilmente da cercare nei cambiamenti dell’alimentazione, più evidenti in Paesi – come l’India – che stanno vivendo un rapido sviluppo industriale.
Cibi sempre più morbidi e ultraprocessati, infatti, non richiedono più lo sforzo masticatorio necessario ai nostri antenati cacciatori e raccoglitori per sminuzzare le dure fibre della carne cruda e la cellulosa dei vegetali. Quella paleo-dieta comportava una significativa usura del primo e del secondo molare, che spesso in età adulta cadevano e venivano così rimpiazzati dal terzo molare, il cosiddetto dente del giudizio. Con l’avvento dell’agricoltura, il consumo di cibi cotti e sempre più raffinati, l’usura dei molari è via via diminuita, così come la forza richiesta dalla masticazione. Nel corso dell’evoluzione, ciò ha comportato una riduzione delle dimensioni della mascella e una minore necessità del terzo molare.
In sette casi su dieci non trovano spazio per erompere
Sebbene oggi i denti del giudizio sembrino aver perso la loro funzione, continuano a rappresentare un fastidioso problema quando non trovano il giusto spazio per erompere, cosa che accade all’incirca nel 70% dei casi. La loro formazione inizia silenziosamente all’età di sette-otto anni; la corona si completa intorno ai 15 anni, mentre la chiusura dell’apice avviene entro i 22. Ed è proprio a partire da questa fase che possono iniziare i dolori.
«La tempistica è soggettiva, ma solitamente i denti del giudizio erompono prima nelle persone che sono state più precoci nel mettere i denti da latte e quelli permanenti», spiega Jason Motta Jones, responsabile del reparto di Chirurgia orale presso l’Humanitas Dental Center e adjunct professor all’Humanitas University di Milano.
Quelli che possono creare più problemi sono quelli dell’arcata inferiore
I denti del giudizio che danno meno fastidio «sono in genere quelli dell’arcata superiore, perché hanno più spazio libero di uscita, mentre quelli dell’arcata inferiore possono essere più problematici perché si trovano nell’angolo ristretto che si viene a creare tra la parte verticale della mandibola, la cosiddetta branca montante, e il corpo mandibolare: se il dente si sviluppa dietro la branca montante, l’eruzione può risultare complessa», sottolinea lo specialista. «Molto dipende anche dall’orientamento del dente, che in mancanza di spazio può spingere contro i denti adiacenti danneggiandoli».
I denti del giudizio non sono connessi a problemi posturali o mal di schiena
A seconda di come procede la crescita del dente, si possono avere diversi esiti. Il terzo molare può rimanere completamente incluso nell’osso, senza erompere mai nel cavo orale: di solito è asintomatico, ma può anche causare cisti o infezioni. A volte può rimanere parzialmente incluso, quando non riesce a sbucare dalla gengiva e resta intrappolato nell’osso, sviluppando dolore e infiammazione. Se invece il dente è in parte visibile nel cavo orale ma non si spinge completamente fuori dalla gengiva, allora si parla di semi-inclusione, una condizione che espone facilmente a infezioni, carie e ascessi.
«Bisogna sfatare il falso mito dei denti del giudizio che causano affollamento dentale e disallineamento: possono essere un co-fattore, ma di certo non l’unico responsabile», precisa Motta Jones. «Non ci sono neppure studi clinici che dimostrino chiaramente una correlazione di causa-effetto tra denti del giudizio e problemi di postura, mal di schiena o acufeni, tanto che la loro estrazione nella maggior parte dei casi non porta alla risoluzione del problema».
Per capire se ci sono problemi bisogno sottoporsi a radiografia panoramica
In caso di dubbi è opportuno rivolgersi al dentista di fiducia, che per valutare la disodontiasi (cioè la difficoltà del dente a erompere) prescriverà innanzitutto una radiografia panoramica. «L’esame, però, ci restituisce un’immagine bidimensionale che può non essere sufficiente quando le radici del terzo molare sono in stretto rapporto di vicinanza con il nervo alveolare inferiore, cioè la terza branca del trigemino che dà la sensibilità alla cute e alla mucose del labbro», aggiunge l’esperto in chirurgia orale.
«In questi casi più complessi può essere necessario ricorrere a un’indagine di secondo livello, un esame diagnostico per denti e ossa che prevede l’utilizzo di un fascio radiante a forma di cono a una dose molto ridotta di raggi X». I dati raccolti permettono così di ricostruire in 3D la posizione del dente rispetto al nervo, facilitando la pianificazione dell’eventuale intervento di estrazione.
Quando bisogno estrarli?
Perché alla fine il dilemma è sempre quello: togliere o non togliere? «Se un tempo l’estrazione del terzo molare veniva fatta in via preventiva, oggi ci sono indicazioni sempre più stringenti: si procede solo in caso di carie, infiammazioni ricorrenti, malattia parodontale, ascessi e cisti», precisa lo specialista di Humanitas. «Spesso si consiglia di estrarre anche il dente del giudizio antagonista che si trova sull’arcata opposta, se ci sono segni di possibile sofferenza, in modo da intervenire in una volta sola su un lato della bocca lasciando la possibilità di masticare dall’altro. L’estrazione di tutti e quattro i denti del giudizio, invece, è un approccio più americano, meno praticato in Italia».
L’età migliore per intervenire è intorno ai 18-20 anni, aggiunge l’esperto, perché «dopo i 22 anni le radici del dente raggiungono la completa maturazione e si ancorano più saldamente al substrato osseo, rendendo l’estrazione più complicata».
Come avviene l’intervento
L’intervento può essere fatto dal dentista di fiducia, da uno specialista in chirurgia orale o da un chirurgo maxillo-facciale. L’anestesia locale viene somministrata con un’iniezione a livello del tronco nervoso (anestesia tronculare) e tutto intorno al dente (anestesia plessica). «Nella maggior parte dei casi il dente viene sezionato, in modo da eseguire un’estrazione mininvasiva attraverso un lembo di accesso più piccolo e con una minore asportazione di osso», afferma il dottor Motta Jones.
«Si può utilizzare uno strumentario rotante, in pratica una piccola fresa che taglia tutto quello che trova, oppure uno strumentario piezoelettrico, un’innovazione che ha rivoluzionato la chirurgia ossea odontoiatrica perché permette di tagliare solo le strutture dure (osso e dente) preservando le strutture molli, incluse le fibre nervose. Inoltre consente un taglio micrometrico molto conservativo, che permette un miglior recupero post-intervento».
Ridotto l’uso di antibiotici
Uno degli aspetti più dibattuti rimane quello dell’uso degli antibiotici. «Un tempo venivano prescritti di routine, mentre oggi, per arginare l’emergenza dell’antibiotico-resistenza, il loro impiego è stato ridotto al minimo necessario, solo in caso di infezione in corso, o in casi complessi», puntualizza lo specialista. «Proprio per contenere i rischi, un paio di giorni prima dell’intervento si comincia una terapia antisettica con collutorio alla clorexidina in modo da abbattere la carica batterica nel cavo orale».
Sono invece imprescindibili i farmaci antinfiammatori non steroidei, che vanno presi per due o tre giorni dopo l’intervento, e poi al bisogno, per ridurre dolore e gonfiore. Per contenere ancora di più l’edema, si può anche ricorrere all’iniezione locale di un farmaco cortisonico nel muscolo masticatorio prima dell’intervento, subito dopo l’anestesia. Una volta fatta l’estrazione, il collutorio alla clorexidina rimane essenziale per garantire l’igiene della bocca nei primi giorni, quando ancora non si può usare lo spazzolino in prossimità dell’area operata per via della ferita suturata.
«Il consiglio per le prime ore è applicare ghiaccio sulla guancia e non sciacquare la bocca con acqua, perché si rischia di rimuovere il coagulo che si forma naturalmente a protezione della ferita, facendo ripartire la perdita di sangue», ammonisce Motta Jones. «Per i primi due giorni si raccomanda infine di mangiare cibi freddi e morbidi, evitando verdure a foglia, semi e chicchi, che potrebbero incastrarsi nel sito operato».
Testo di Elisa Buson